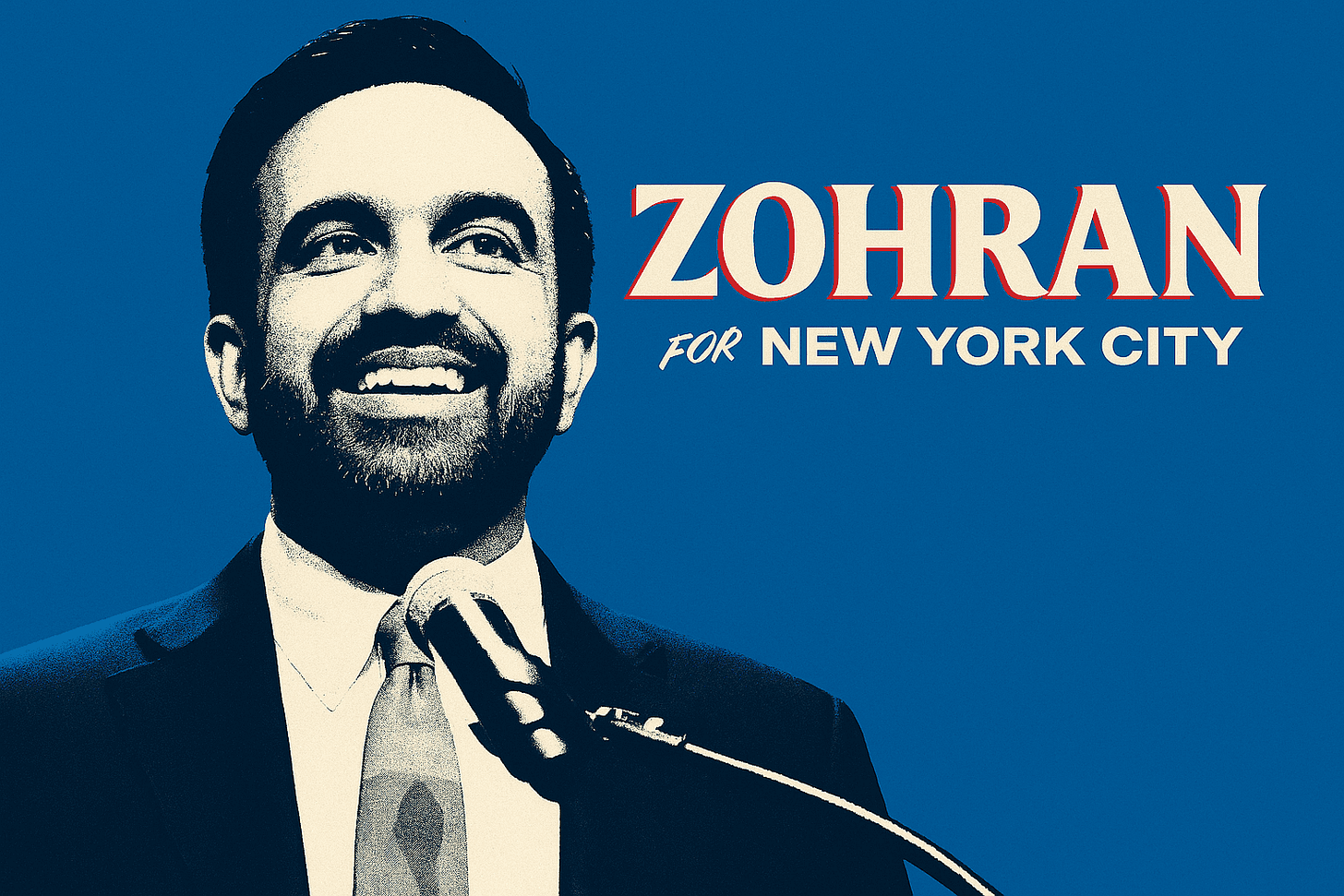Chi è Zohran Mamdani, il socialista che ha conquistato New York
Con oltre un milione di voti ha travolto Andrew Cuomo e l'establishment democratico. Ora promette bus gratis, affitti bloccati e una città più vivibile
Martedì scorso Zohran Mamdani ha fatto la storia: a 34 anni è diventato il nuovo sindaco di New York, sconfiggendo l’ex governatore Andrew Cuomo e il repubblicano Curtis Sliwa in un’elezione che ha ribaltato tutte le previsioni. È il più giovane primo cittadino da oltre un secolo, il primo musulmano e il primo sudasiatico a guidare la metropoli, oltre che il secondo sindaco dichiaratamente socialista nella storia della città. Il suo volto, sorridente, barba corta, giacca senza cravatta, è già l’immagine di una nuova stagione politica: una New York multirazziale, affittuaria, arrabbiata per il costo della vita e desiderosa di risposte concrete. Nel giro di pochi mesi, un deputato di quartiere quasi sconosciuto è diventato la figura più discussa della sinistra americana, conquistando più di un milione di voti: nessuno ne aveva mai presi tanti dai tempi del 1969.
La sua vittoria ha travolto i vecchi equilibri e scatenato una reazione altrettanto potente. Cuomo, erede di una dinastia democratica e simbolo dell’establishment, ha cercato di trasformare la corsa in un referendum sull’identità del partito, accusando Mamdani di essere un estremista “woke”, un islamista mascherato, un pericolo per la sicurezza di Israele. I super-Pac finanziati da Michael Bloomberg e Bill Ackman hanno speso oltre quaranta milioni di dollari per dipingerlo come un fanatico, arrivando a usare immagini delle Torri Gemelle in fiamme. Donald Trump, dal canto suo, lo ha bollato come “liddle’ communist” e ha minacciato di tagliare i fondi federali alla città. Ma mentre lo demonizzavano da destra e dall’alto, Mamdani continuava a parlare a chi vive nei quartieri, viaggia in bus, paga affitti insostenibili e sente di non avere più voce: “La vita non deve essere così dura”, ripeteva nei comizi. “È compito del governo renderla vivibile”.
Come ha vinto Mamdani
Il New York Times ha collocato la svolta decisiva della campagna di Zohran Mamdani nel periodo successivo alle primarie di giugno. Fino a quel momento la sua candidatura era apparsa quasi una sfida culturale, più che una reale corsa al potere: un esperimento per mostrare come potesse funzionare una campagna “muscolare” di sinistra in una città dominata dai super-PAC e dai grandi donatori. Il tono era quello di un movimento più che di una macchina elettorale: riunioni nei caffè yemeniti di Astoria, tornei di calcetto al posto dei comizi, merchandising distribuito solo a chi faceva volontariato, una comunicazione diretta, in stile AOC o Trump, che saltava media e associazioni storiche per parlare direttamente agli elettori. Ma la vittoria inattesa alle primarie cambia tutto. Lo staff, spiazzato, passa in poche settimane da un’organizzazione quasi artigianale a una struttura professionale: nuovi portavoce, una strategia disciplinata, briefing quotidiani e una scelta consapevole di tono più “istituzionale”. È in quel momento che nasce la doppia anima della campagna: da un lato la continuità con il messaggio radicale sull’affordability; dall’altro, un lavoro di costruzione di fiducia verso i mondi che lo temevano di più, business, istituzioni, sindacati, filantropie.
Proprio il corteggiamento al mondo economico diventa una delle mosse più delicate e, alla lunga, decisive. Mamdani inizia a incontrare amministratori delegati, real estate developer, rappresentanti delle grandi fondazioni newyorkesi. All’inizio lo fanno per dovere di protocollo; dopo il secondo incontro, molti tornano con una percezione diversa. Kathryn Wylde, presidente della Partnership for New York City, racconta che “la paura iniziale si è sciolta nel contatto diretto: Mamdani ascolta, non improvvisa, sa discutere di regole, di urbanistica, di economia reale”. Alcuni dei suoi alleati insistono su un punto: “competenza e giustizia sociale non sono incompatibili”. Mamdani lo traduce in una formula: efficienza come valore progressista. È un linguaggio che piace alle imprese, anche se non cancella del tutto il sospetto. I CEO continuano a vedere un sindaco che vuole tassare i ricchi e costruire più case pubbliche; ma per la prima volta percepiscono un interlocutore, non un nemico.
Sul piano elettorale, Mamdani ridisegna la mappa politica di New York. Consolida il suo dominio nella “commie corridor” lungo il waterfront di Brooklyn, da Brooklyn Heights a Fort Greene, passando per Park Slope, Bushwick e Williamsburg, dove in alcuni distretti supera l’80 per cento. Conquista i quartieri giovani e gentrificati dell’Upper Manhattan e del Lower East Side, ma soprattutto sfonda nei territori working class. Nel Bronx, dove alle primarie era stato sconfitto di 18 punti, vince di 11 nel voto finale; a Brownsville ribalta un -40 in un +18; nel Queens trionfa ad Astoria, Jackson Heights e Corona, saldando orgoglio identitario e agenda economica. Cuomo, al contrario, si rifugia nei quartieri dell’élite, Upper East e Upper West Side, le zone ebraiche ortodosse di Brooklyn, Staten Island e il sud bianco e conservatore di Brooklyn, troppo ristretti per colmare il divario numerico.
Un altro passaggio cruciale è il rapporto con la destra. Correndo come indipendente, Cuomo svuota quasi tutto lo spazio repubblicano: convince buona parte degli elettori di Trump che votare Curtis Sliwa sarebbe “sprecare” il voto, portandolo al 7 per cento, la peggior performance del GOP in una municipale da decenni. Ma in quello stesso vuoto Mamdani pesca una quota sorprendente di “Trump–Mamdani voters”: portoricani, sudamericani, sudasiatici e musulmani che avevano scelto Trump nel 2024 per rabbia verso l’establishment e che ora votano per lui come unico capace di rompere il sistema e abbassare i costi di vita. L’analista Michael Lange parla di una “coalizione multirazziale della classe precaria”: giovani affittuari con laurea, lavoratori dei servizi, famiglie nere e latine dei quartieri popolari, immigrati che si muovono in bus e metro, uniti da una stessa impazienza verso un’élite urbana che parla di inclusione ma lascia crescere gli affitti.
Alla fine Mamdani chiude con il 50,4 per cento e oltre 1,1 milioni di voti, più di qualsiasi candidato dal 1969. Non è un trionfo unanime, ma un mandato forte, costruito su un’affluenza record (oltre due milioni di elettori) e su un equilibrio raro: radicalità nel messaggio e pragmatismo nella forma. Quando sul palco del Brooklyn Paramount ha detto che “questa città torna ad appartenere a chi la vive, non a chi la possiede”, lo ha fatto con la voce di chi sa di aver spostato il baricentro politico di New York. Ora dovrà dimostrare che si può governare con lo stesso mix di idealismo e calcolo che lo ha portato fin qui.
Le proposte di Mamdani
Il cuore del programma di Zohran Mamdani si riassume in una formula: “A City We Can Afford”. Tutta la sua narrazione ruota attorno all’idea di affordability, cioè alla possibilità concreta per chi vive e lavora a New York di restarci. Sul fronte abitativo, il piano è ambizioso e politicamente rischioso: congelare per tutto il mandato gli affitti delle unità a regolazione, triplicare l’offerta di alloggi accessibili costruendo 200 mila nuove case in dieci anni e raddoppiare gli investimenti per la manutenzione del patrimonio pubblico, a partire dalle housing projects del NYCHA. Durante la campagna, Mamdani ha evitato per mesi di dire come si sarebbe schierato sui tre referendum proposti dal sindaco uscente Eric Adams per accelerare l’edilizia; poi, il giorno stesso del voto, ha rotto il silenzio e ha detto “sì”. Le misure riducono il potere di veto dei consiglieri comunali e rafforzano quello del sindaco e del City Planning Department: una scelta coerente con la logica YIMBY (“build, baby, build”) ma che apre una tensione interna alla sinistra, tra i quartieri che chiedono più case e i sindacati che usano il veto per ottenere garanzie sui contratti e sugli standard sociali. Come e se Mamdani userà davvero questi nuovi poteri sarà uno dei primi banchi di prova del suo mandato.
Sul terreno economico-sociale, la sua “trinità” è ormai nota: rent freeze, bus fast and free, child care universale. Il piano per l’infanzia promette asili e nidi gratuiti dai 6 mesi ai 5 anni, “baby basket” con beni essenziali per ogni neonato e tasse universitarie azzerate per CUNY. Secondo le stime interne, il solo pacchetto per la child care costerebbe circa 6 miliardi di dollari l’anno, più altri fondi per borse di studio e infrastrutture educative. Per finanziarlo, Mamdani propone di aumentare la corporate tax statale fino all’11,5 per cento e di ritoccare di due punti l’aliquota sull’1 per cento più ricco, insieme a un giro di vite sull’evasione e sui contratti opachi del Department of Education. Gli economisti progressisti sottolineano i possibili ritorni: più donne nel mercato del lavoro, più ore lavorate, salari più alti e maggiore produttività. Ma i limiti restano enormi: politici (bisognerà convincere Albany) e pratici, perché trovare educatori ben pagati e garantire qualità uniforme in una città già frammentata nei servizi 0-5 è tutt’altro che semplice.
L’altra bandiera è quella dei bus gratuiti e veloci, inaugurata simbolicamente con l’evento sulla linea M57, la più lenta di New York, percorsa con giornalisti e pendolari a 2,3 miglia all’ora. Mamdani vuole abolire il biglietto su tutta la rete, un’operazione che costerebbe meno di 800 milioni l’anno, e rivoluzionare il trasporto di superficie con corsie preferenziali estese, busway che limitano le auto sulle arterie principali, nuove fermate e priorità semaforiche. È una misura di redistribuzione materiale: tempo, denaro e comfort a favore di chi non possiede un’auto, in una città dove i frequent rider dei bus sono più poveri, più anziani e più spesso persone di colore. Ma le incognite restano: come compensare le perdite di bigliettazione senza sottrarre fondi alla metro e come resistere alla reazione degli automobilisti e dei commercianti contrari alle corsie riservate. Il precedente di Kansas City, che ha dovuto ridimensionare il bus gratuito per mancanza di fondi, è già diventato munizione negli spot dei suoi oppositori.
Sulla sicurezza, Mamdani tenta un equilibrio complesso: passare da “defund the police” a “reimmaginare il perimetro della polizia” senza alienare la propria base. Propone la creazione di un Department of Community Safety da un miliardo di dollari, che unisca e potenzi programmi già esistenti: squadre di salute mentale tipo B-HEARD al posto della polizia in molte chiamate al 911, navigator nei quartieri per collegare chi è in crisi ai servizi, team di outreach nelle stazioni della metro, ampliamento dei violence interrupters che mediano i conflitti prima che esplodano. Non promette tagli agli agenti, ma vuole agire su due tabù: il maxi-budget per gli straordinari e la Strategic Response Group, l’unità antisommossa che gestisce proteste e grandi eventi. Per rassicurare il mondo economico e i moderati, ha annunciato che intende confermare Jessica Tisch come commissaria del NYPD: tecnocrate stimata dagli ambienti finanziari e amata dalle élite urbane, ma vista con sospetto dalla sinistra. Il rischio, evidente, è quello di finire tra due fuochi: i sindacati di polizia che difendono prerogative e straordinari, e una base che non accetterebbe un ritorno allo status quo.
Sul fronte educativo e istituzionale, Mamdani mira a scardinare il “mayoral control” voluto da Bloomberg, che assegna al sindaco poteri quasi assoluti sulle scuole, per sostituirlo con un modello più partecipativo in cui genitori e docenti abbiano voce reale su curricoli, chiusure e spese. Non vuole tornare ai consigli scolastici corrotti degli anni Novanta, ma immagina un sistema ibrido: il sindaco continua a nominare il cancelliere, ma con organi rappresentativi più forti e trasparenti. Finora, tuttavia, il suo discorso ha insistito più sulle regole che sui risultati: dispersione scolastica, livelli di lettura bassissimi e divari etnici restano nodi aperti, e molti temono che l’enfasi sulla governance rischi di assorbire energie senza migliorare la qualità dell’insegnamento.
E poi c’è il dossier più incendiario: Israele, Gaza e antisemitismo. Mamdani ha definito Israele “uno Stato di apartheid”, ha paragonato l’offensiva su Gaza a un genocidio e sostiene apertamente il movimento BDS. Ha rifiutato per mesi di condannare lo slogan “Globalize the Intifada” e ha promesso di far arrestare Netanyahu se dovesse arrivare a New York in virtù del mandato della Corte penale internazionale. Parallelamente, però, rivendica un piano massiccio contro i crimini d’odio e insiste sul fatto che combattere antisemitismo e islamofobia fa parte integrante del suo mandato. La reazione dell’ebraismo istituzionale è stata durissima: la UJA-Federation e l’Anti-Defamation League hanno annunciato task force per monitorare ogni sua nomina e ogni politica del suo esecutivo. È la prova più delicata per un sindaco che vuole essere, insieme, il volto di una città santuario e il simbolo di una nuova sensibilità progressista sul Medio Oriente. Da come saprà tenere questo equilibrio, garantendo sicurezza e rispetto a tutte le comunità, senza rinunciare alle proprie convinzioni, dipenderà gran parte del giudizio sul suo mandato.
La città divisa che eredita
Dietro la narrativa del “mandato storico” si intravede una città profondamente divisa per religione, classe e territorio. Il voto ebreo, soprattutto nelle comunità ortodosse di Brooklyn e nei quartieri benestanti dell’Upper East e dell’Upper West Side, si è schierato in massa con Andrew Cuomo: non tanto per adesione, quanto per paura. Per molti elettori rappresentava l’unico argine a un candidato percepito come ostile a Israele. Subito dopo il voto, le principali federazioni ebraiche di New York e del New Jersey hanno diffuso un comunicato in cui affermano che Mamdani “incarna convinzioni in conflitto con i nostri valori più profondi”, promettendo di vigilare affinché la città resti “un luogo sicuro e rispettoso per la comunità ebraica”. L’Anti-Defamation League ha annunciato la creazione di un’unità speciale per monitorare le politiche e le nomine della nuova amministrazione. Sul fronte opposto, invece, le comunità musulmane e sudasiatiche, insieme a molte realtà nere e latine, hanno vissuto la vittoria come un riscatto identitario e materiale: l’ascesa di un sindaco che “parla la nostra lingua, prende i nostri bus e vive i nostri problemi”.
Anche il rapporto con il business nasce da un reciproco sospetto. Gran parte dei CEO e dei grandi developer ha finanziato i super-PAC anti-Mamdani, convinta che un democratico socialista rappresentasse una minaccia per l’ordine economico e per la sicurezza di Israele. Ma nelle riunioni a porte chiuse raccontate dalle cronache, molta di quella diffidenza si è attenuata. Mamdani ha chiarito che alcune posizioni non cambieranno, tasse più alte per i redditi maggiori, più edilizia pubblica, più regole per i grandi capitali, ma ha anche ascoltato, posto domande e mostrato di conoscere la macchina amministrativa meglio di quanto molti immaginassero. Ha insistito sull’idea che efficienza e lotta agli sprechi siano valori progressisti, non conservatori, e che una città più giusta ha bisogno di istituzioni che funzionino bene. Figure come Kathryn Wylde, presidente della Partnership for New York City, hanno riconosciuto che il solo fatto di aver accettato quei meeting “ha abbassato l’isteria di qualche tacca”.
Ora la partita si sposta sulle nomine, dove Mamdani può dimostrare di voler governare, non solo contestare. La conferma di Jessica Tisch al vertice del NYPD, una tecnocrate amata da Wall Street e rispettata anche nei circoli moderati, va in questa direzione, così come la promessa di scegliere professionisti di alto profilo ai vertici del bilancio e della pianificazione urbana. Per il mondo economico, saranno questi gesti concreti, più dei discorsi o dei tweet, a dire se il nuovo sindaco è davvero un pericolo o piuttosto un interlocutore con cui si può convivere.
Le altre elezioni: Virginia, New Jersey e California
Mentre Mamdani ribaltava gli equilibri a New York, il resto del paese mandava un segnale altrettanto chiaro: dieci mesi di seconda amministrazione Trump hanno spostato l’umore dell’elettorato. In Virginia, Abigail Spanberger è diventata la prima donna a governare lo Stato in 246 anni di storia, sconfiggendo la vicegovernatrice repubblicana Winsome Earle-Sears con quasi quindici punti di scarto. Ex agente della CIA ed ex deputata, Spanberger ha costruito tutta la campagna su un tema preciso: i 320.000 lavoratori federali della Virginia, più centinaia di migliaia di contractor, colpiti dai licenziamenti di massa voluti dalla Casa Bianca. “L’economia della Virginia è sotto attacco”, ha ripetuto nei comizi, evitando però di trasformare la campagna in un comizio anti-Trump: nel discorso di vittoria ha ringraziato anche chi l’aveva avversata, promettendo di servire “tutti i virginiani”. La sua avversaria, invece, aveva puntato tutto sui temi transgender, bagni scolastici, sport femminili, spogliatoi, ma gli elettori, sondaggio dopo sondaggio, continuavano a dire che il loro problema era un altro: il costo della vita. Persino Chris LaCivita, ex stratega di Trump, ha ammesso a urne chiuse che “un cattivo candidato e una cattiva campagna hanno conseguenze”.
In New Jersey, stessa dinamica. Mikie Sherrill, ex pilota della Marina, ex procuratrice federale, deputata moderata dal 2018, ha battuto il repubblicano Jack Ciattarelli con il 56 per cento, diventando la seconda donna a guidare lo Stato e la prima democratica. È la terza vittoria consecutiva dei democratici alle elezioni per governatore, un risultato che non si verificava dal 1961. Sherrill ha fatto della bolletta elettrica, aumentata del 22 per cento nell’estate 2024, più di ogni altro Stato tranne il Maine, il fulcro della sua campagna, promettendo di dichiarare lo stato di emergenza sui costi energetici nel primo giorno di mandato. Ha attaccato Trump per la minaccia di cancellare i nuovi tunnel ferroviari sotto il fiume Hudson e ha accusato i suoi dazi di affossare l’economia. Anche qui, Ciattarelli ha cercato di aggrapparsi all’endorsement presidenziale, arrivato solo a maggio tra l’altro, ma non è bastato: il New Jersey resta solidamente democratico, anche se le presidenziali del 2024 avevano visto Trump guadagnare terreno tra i lavoratori e le minoranze.
Sul fronte più tecnico ma altrettanto decisivo, la California ha approvato la Proposition 50 con il 64,3 per cento dei voti: una misura che autorizza il ridisegno delle mappe dei distretti congressuali in chiave democratica, per rispondere alle operazioni simili condotte dai repubblicani in Texas e in altri Stati rossi. Il governatore Gavin Newsom l’aveva promossa come necessaria per contrastare i tentativi di Trump di manipolare i confini elettorali a vantaggio del GOP. Se pienamente attuata, la riforma potrebbe far guadagnare ai democratici fino a cinque seggi alla Camera nelle elezioni di medio termine del 2026, un margine che, in un Congresso diviso, può fare la differenza.
Altrove, altre vittorie minori ma simboliche: in Pennsylvania tre giudici della Corte Suprema statale sostenuti dai democratici hanno mantenuto i loro seggi, garantendo al partito il controllo 5-2 della corte; in Virginia, Jay Jones è diventato il primo afroamericano a ricoprire la carica di procuratore generale, nonostante uno scandalo legato a messaggi violenti emersi nelle ultime settimane. Ken Martin, presidente del Democratic National Committee, ha parlato di “inizio della rinascita democratica”. Solo Virginia e New Jersey tengono elezioni per governatore l’anno successivo a quello presidenziale, e i risultati sono tradizionalmente considerati un indicatore delle tendenze nazionali. Questa volta, il segnale sembra netto: l’opposizione a Trump funziona, ma solo se ancorata a problemi concreti, costi di vita, bollette, stipendi, e non a retoriche ideologiche. È la lezione che i democratici porteranno nelle elezioni di medio termine del 2026, quando tutti i seggi della Camera e un terzo del Senato saranno in palio.
Le altre notizie della settimana
La Corte Suprema blocca i buoni alimentari per milioni di americani. La giudice Ketanji Brown Jackson sospende l’ordine che obbligava l’amministrazione Trump a pagare i benefici completi per novembre. Alcuni stati erano già riusciti a distribuire i fondi prima del blocco.
È morto Dick Cheney, il vicepresidente più potente della storia americana. Il 46° vicepresidente degli Stati Uniti, architetto della “guerra al terrore” e critico feroce di Donald Trump negli ultimi anni, si è spento a 84 anni per complicazioni legate a polmonite e malattie cardiovascolari.
La Corte Suprema non sembra convinta dei dazi globali di Trump. I giudici della Corte Suprema, inclusi tre nominati dallo stesso presidente, hanno espresso forte scetticismo durante l’udienza sulla legittimità dei dazi imposti unilateralmente dall’amministrazione Trump su scala mondiale
Precipita la popolarità di Trump: siamo al momento peggiore del secondo mandato. Prosegue lo shutdown e prosegue il momento difficile di Trump, che perde due punti rispetto a settimana scorsa con gli indici di gradimento che sprofondano al punto più basso del mandato, superando anche il periodo dei dazi ad aprile.
I Dem sono visti come “woke” e “deboli” dalla classe operaia. Una ricerca interna durata nove mesi e condotta in 21 stati rivela che gli elettori operai considerano il partito “progressista, debole e fuori dal mondo”. I dati mostrano un distacco profondo su temi economici e priorità, con aperture però per riconquistare consensi.
Trump entra nell’era dell’anatra zoppa, i repubblicani iniziano a prendere le distanze. Dopo la pesante sconfitta elettorale di martedì, il presidente ha chiesto al Senato di abolire il filibuster ma i senatori repubblicani lo hanno ignorato. Cresce la consapevolezza che Trump non sarà più candidabile mentre loro dovranno affrontare gli elettori nel 2026.
Vance si prepara a guidare il trumpismo per il 2028. Il vicepresidente americano consolida la sua posizione nel movimento MAGA con un tour nei campus universitari. Punta sull’immigrazione, la fede e un nuovo approccio alla politica estera per candidarsi alla presidenza.
La vittoria dei Dem e il paradosso repubblicano: forti con Trump, deboli senza lui, Commento sulla nottata elettorale, tra i democratici rinvigoriti e il campanello d’allarme per un partito repubblicano che non può più contare solo sull’effetto dell’onda trumpista.
Trump ha capito Gramsci meglio della sinistra. Il columnist del New York Times David Brooks sostiene che il movimento MAGA ha adottato tattiche e concetti rivoluzionari nati a sinistra, dal postmodernismo alla teoria critica, ribaltandoli contro i progressisti stessi.